Le principali fasi di transizione della vita:
La vita è caratterizzata da una serie di passaggi fondamentali che segnano la crescita e il cambiamento. Queste fasi, pur essendo comuni, sono vissute in maniera diversa da ciascun individuo e portano con sé sfide psicologiche importanti. La teoria dello sviluppo psicosociale di Erik Erikson (1950), ad esempio, identifica otto stadi di sviluppo, ognuno dei quali comporta una crisi da risolvere per proseguire nel percorso di crescita. Tra questi, la transizione dall’adolescenza all’età adulta, la scelta del percorso di studi e professionale, l’ingresso nel mercato del lavoro, e la formazione di una propria famiglia sono momenti chiave che possono determinare mutamenti nel benessere psicologico di una persona.
Un primo grande momento di cambiamento riguarda l’affacciarsi alle prime relazioni affettive durante il periodo adolescenziale, che segna il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Durante questa fase, gli individui iniziano a sperimentare legami più profondi e intimi, ma possono anche affrontare l’ansia da separazione, la paura del rifiuto e la difficoltà nel costruire una propria identità affettiva. Le emozioni di incertezza e di fragilità possono influenzare profondamente l’autostima, portando a esperienze di insoddisfazione se non accompagnate da un adeguato supporto emotivo e da un processo di riflessione cognitiva.
La scelta del percorso di studi e la carriera rappresenta un altro snodo critico. La teoria del ciclo di vita professionale di Donald Super (1957) suggerisce che la carriera non è un aspetto statico della vita, ma un processo che evolve in vari stadi. La difficoltà di conciliare le proprie inclinazioni personali con le aspettative lavorative può comportare stress da adattamento e incertezze riguardo al futuro. La paura di fare una scelta errata o di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi può generare ansia anticipatoria e difficoltà nell'assumere decisioni.
L’ingresso nel mercato del lavoro, soprattutto in un contesto altamente competitivo e incerto, è un altro momento di transizione che porta con sé emozioni contrastanti. L'Alto livello di competitività, la crescente precarietà del lavoro e le difficoltà di emergere in un mondo professionale sempre più globalizzato possono suscitare sensazioni di frustrazione, insoddisfazione e senso di inadeguatezza. L'incapacità di raggiungere immediatamente risultati visibili e la continua pressione per l’auto-affermazione possono generare un circolo vizioso di vissuti negativi.
Infine, le aspettative relazionali e familiari rappresentano un altro ambito di transizione fondamentale. La società moderna enfatizza l'importanza di realizzarsi in un contesto relazionale e familiare, con obiettivi come il matrimonio e la genitorialità che vengono spesso visti come espressioni di successo. Tuttavia, quando queste aspettative non si realizzano nei tempi desiderati, può insorgere un senso di frustrazione, insoddisfazione e inadeguatezza.
Le reazioni psicologiche implicate
Ogni fase di transizione comporta una serie di risposte emotive che vanno dalla preoccupazione all’incertezza, fino alla frustrazione e all’ansia. La teoria del coping di Lazarus e Folkman (1984) sottolinea che la gestione dello stress e dei cambiamenti dipende difatti dalla valutazione che l'individuo fa della situazione e dalle risorse psicologiche disponibili per affrontarla.
In questo senso, la preoccupazione per il futuro è una delle risposte più comuni durante i periodi di transizione. L’incertezza legata al cambiamento porta spesso a ruminazioni incessanti su ciò che accadrà, creando un circolo vizioso che può alimentare l’ansia. Secondo la teoria dell’elaborazione del rischio, una persona che percepisce un alto rischio di insuccesso in una transizione può sperimentare anche un forte stress anticipatorio, un fenomeno noto anche come "ansia da prestazione". Questo fenomeno è particolarmente evidente quando ci si trova a fare scelte che influenzeranno profondamente il proprio futuro.
La risonanza con scelte fatte nel passato è un altro aspetto centrale del vissuto psicologico nelle fasi di transizione. Le persone che affrontano questi periodi possono provare rimorso o insoddisfazione per le decisioni passate, alimentando la dissonanza cognitiva, fenomeno per cui un soggetto sperimenta una discrepanza tra le proprie aspettative e la realtà delle circostanze. In questo caso, si può sperimentare un disagio psicologico che spinge la persona a cercare modi per ridurre la tensione che ne deriva, ad esempio modificando le proprie convinzioni, giustificando la situazione o cercando di cambiare comportamento.
Inoltre, l’impossibilità di vedere i frutti immediati dei propri sforzi, unita a continui confronti con gli altri, può portare a un’escalation di frustrazione e senso di inadeguatezza crescente. Le persone che vivono transizioni difficili tendono, delle volte, a focalizzarsi su ciò che manca, anziché sui progressi realizzati, alimentando il pensiero negativo e la percezione di fallimento, rendendo ardua la capacità di adattarsi al cambiamento.
Inoltre, la fluttuazione emotiva è una caratteristica frequente di questi periodi, poiché l’individuo si trova a dover adattarsi a nuove circostanze. La difficoltà nel gestire l’incertezza e la percezione di instabilità emotiva è spesso legata alla percezione di perdita di controllo sulla propria vita, fenomeno che può provocare disorientamento e ansia.
Affrontare le transizioni
Affrontare i periodi di transizione con successo richiede dunque l’utilizzo di strategie di coping funzionali, che siano in grado di minimizzare lo stress e migliorare l’adattamento alle nuove sfide, riducendo i livelli di stress e favorendo il benessere psicologico
Una delle prime risorse da attivare è la consapevolezza delle proprie emozioni. Riconoscere il proprio stato d’animo, senza giudicarlo, permette di affrontare la difficoltà con maggiore serenità. Imparare ad accettare le emozioni negative, piuttosto che evitarle, può essere un passo importante verso una maggiore resilienza.
Un altro strumento utile è la ristrutturazione cognitiva, che implica un cambiamento nel modo di interpretare le situazioni difficili. Invece di vedere le transizioni come una minaccia, si può cercare di considerarle come opportunità di crescita o come fasi di adattamento necessarie per il benessere a lungo termine. Questo tipo di pensiero più positivo non significa ignorare le difficoltà, ma imparare a dare un senso costruttivo a ciò che sta accadendo.
Anche il supporto sociale gioca un ruolo cruciale: parlare con amici, familiari o professionisti consente di non sentirsi soli e di ottenere nuove prospettive. La condivisione delle proprie esperienze con persone che ci capiscono può portare a soluzioni pratiche e a una maggiore sensazione di vicinanza emotiva. Inoltre, non bisogna sottovalutare l’importanza di prendersi del tempo per sé stessi, dedicandosi a pratiche come la meditazione, lo yoga o anche semplicemente a una passeggiata allaria aperta. Questi momenti di introspezione e cura personale offrono spazio per riflettere, ricaricare le energie e rimanere centrati nel presente.
Infine, l’adattabilità è una qualità fondamentale da coltivare. Accettare che i cambiamenti fanno parte della vita e che non sempre è possibile prevedere ogni aspetto di una transizione aiuta a sviluppare un atteggiamento più flessibile. Imparare a vivere con l’incertezza, senza sentirsi sopraffatti, permette di affrontare ogni nuova fase con una maggiore apertura mentale e una serenità più duratura.
Conclusione
Le transizioni della vita, pur essendo inevitabili, non devono essere affrontate in modo passivo o disfunzionale. La comprensione dei propri vissuti emotivi, l’utilizzo di strategie di coping efficaci e il supporto sociale e psicologico possono trasformare questi periodi di incertezza in opportunità di crescita. Affrontare il cambiamento con consapevolezza e resilienza è la chiave per navigare con successo le sfide che la vita ci presenta.
Bibliografia
-
Ehlers, A., & Clark, D. M. (2020). Cognitive models of anxiety and depression in major life transitions. Behavior Research and Therapy, 131, 103711. https://doi.org/10.1016/j.brat.2020.103711
-
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company.
-
Côté, J. E., & Levine, C. G. (2002). Identity, formation, agency, and culture: A social psychological synthesis. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
-
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W.H. Freeman and Company.
-
Shifren, K., & Meade, T. (2017). The role of coping in successful life transitions. Journal of Counseling Psychology, 64(5), 572-581. https://doi.org/10.1037/cou0000201




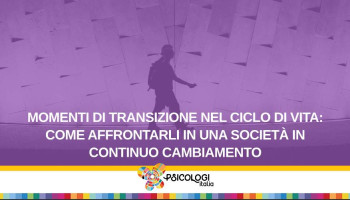
commenta questa pubblicazione
Sii il primo a commentare questo articolo...
Clicca qui per inserire un commento