Anni fa una mia paziente che seguivo da tempo, ha cominciato a coltivare il sogno di una gravidanza e si è imbattuta in una serie d’angosce relative alla sua maternità. Il suo tormento più grande consisteva nella domanda: “Sarò capace di comprendere i bisogni, le richieste del mio bambino?”. Nella sua mente un neonato non poteva fare altro che piangere, e lei come avrebbe fatto a capirlo senza farsi sommergere dall’angoscia delle sue grida? Questa aspirante mamma in quel periodo stava cercando di padroneggiare alcune sue sofferenze psicologiche che le impedivano di guardare con serenità ai suoi naturali desideri.
Ancora non aveva idea di quanto sarebbe stato gratificante “costruire” insieme con lui un “loro” modo di intendersi, un linguaggio specifico e speciale per capirsi reciprocamente. Partendo dal pianto, certo, per arrivare poi a tutto un mondo relazionale per così dire, a colori.
Il pianto del neonato è un evento che attiva immediatamente la preoccupazione dell’adulto. L’urgenza per quest’ultimo di trovare subito una risposta, spesso interrompe il fluire del pensiero: il pianto del bebè è una comunicazione emotiva, non verbale. Per l’adulto che se ne occupa l’unica possibilità è quella di rispondere appunto sul piano emotivo con manovre consolatorie.
Va anche detto che il neonato è fisiologicamente disposto al pianto. Al momento della nascita il suo pianto, più un grido, un singhiozzo che un pianto, serve al bebè per svuotare e riempire i polmoni. E’ il movimento necessario per passare da una circolazione sanguigna parassitaria a una autonoma sostituendo l’ossigeno del sangue materno della gravidanza con quello del proprio respiro.
Non poche ragioni di preoccupazione però la mia paziente le aveva: c’è del vero nel fatto che il pianto si presenti apparentemente come l’unico modo del neonato di comunicare, e fondamentalmente quel pianto è una richiesta d’aiuto.
Se però riusciamo ad ascoltarlo con un po’ di empatia, esso può anche rivelarci tutte le sue caratteristiche di vera e propria comunicazione evoluta.
A un primo sguardo il pianto appare come un comportamento che serve al bebè per avvicinare la madre e soddisfare le necessità fisiologiche relative alla sua sopravvivenza. Da segnale indifferenziato, gradualmente assumerà una vasta gamma di sfumature e gradazioni. Diventerà un segnale intenzionale solo diverso tempo dopo. Le varie modalità di risposta materna a queste forme primitive di segnalazioni trasformeranno “la selva in campo” (Fornari, 1973), in una sorta di codice con chiari significati relazionali, rendendo sempre più comprensibile per entrambi, madre e bambino, la reciproca comunicazione.
Dicevamo che il pianto è sia una risposta dell’organismo a stimoli interni, sia una richiesta d’aiuto. Molte volte però le cause del pianto non sono specifiche cause organiche, e nemmeno chiare richieste di soccorso: ci sono casi in cui si riesce a far cessare il pianto fornendo al bambino un semplice stimolo come la voce umana o il contatto fisico. Un bambino di 5 settimane può mettersi a piangere se una persona che lo sta a guardare scompare dalla sua vista. Il pianto ha dunque una complessa ma chiara dimensione relazionale, e dimostra come il neonato sia essenzialmente un essere sociale fin dalla nascita (1).
Potrebbero esserci svariati motivi per cui un bambino piange, ma una mamma “sufficientemente buona”, senza che nessuno glielo spieghi, sa che il pianto del suo bambino, quello che comincia sommessamente, a bassa intensità e che diventa mano a mano più forte, è collegato in un qualche modo alla fame. Diventerà una richiesta furiosa e disperata solo in caso di ritardo nella sedazione del bisogno di nutrizione. Questo tipo di pianto è l’espressione di una sofferenza fisica, simile a quella provocata dalle coliche o dalle otiti, o anche dalla luce troppo intensa, che il bambino cercherà per come gli sarà possibile, di indicare con movimenti o tensioni specificamente rivolte a indicare la parte dolente.
Una mamma, normalmente distinguerà con facilità questa forma di pianto: un lungo pianto improvviso seguito da un lungo silenzio. A volte sarà un vero e proprio pianto di rabbia, nel quale il bambino sembrerà sopraffatto e posseduto da un’ira incondizionata con urla, strepiti o calci: probabilmente un tentativo di urlare la propria delusione per non essere stato capito, un esercizio di controllo sull’ambiente di accudimento, sentito come inaffidabile.
Può esistere una quarta modalità, il cosiddetto pianto debole e sommesso, fatto di gemiti sussurrati. Questo è un segnale in genere molto allarmante per tutte le mamme: dice che il loro bambino è tanto ammalato da non avere neppure la forza di piangere e reclama di solito un sollecito intervento.
Istintivamente, sentiamo che davanti al pianto di un bebè siamo coinvolti in maniera differente rispetto al pianto di un adulto. Con un adulto ci sentiamo sollecitati ad attuare manovre o comportamenti “agiti” ma anche emotivi e soprattutto affettivi, di consolazione. Il nostro primo gesto spontaneo sarà probabilmente quello di porgere un fazzoletto. Gli forniamo insomma un posto per poter depositare le sue lacrime, un contenitore per il suo dolore. Abbracciamo chi piange, capita anche di piangere insieme, condividiamo il pianto; riconosciamo il perché un adulto piange, se piange di dolore, di rabbia, di eccitazione oppure di gioia.
Un neonato non ha lacrime (2): è questa la causa del nostro frequente timore di sbagliare, di non fare la cosa giusta per contenere il suo dolore? E’ per questo che cerchiamo disperatamente di interrompere il suo pianto prima ancora di capire da cosa bisogna consolarlo? E’ per questo che capita di trovarci in difficoltà a elaborare con il piccolo le sue emozioni?
Consolare non è sinonimo di far cessare, ma recare conforto. Il che presuppone la capacità e la disponibilità dell’adulto di ascoltare per capire, capire per pensare, pensare per rispondere, invece di agire dando una risposta immediata e indifferenziata. Per consolare occorre riconoscere adeguatamente l’emozione sottostante.
Le emozioni del bambino (come le nostre, del resto) hanno un carattere bipolare (positivo-negativo). Noi adulti sappiamo però quanto sia importante cogliere le mille distinzioni, le mille sfumature dei movimenti dell’animo umano: sorpresa, paura, terrore, interesse, eccitazione, godimento, gioia, disagio, angoscia, collera, rabbia, odio, disprezzo, disgusto, vergogna, umiliazione, mortificazione …..
Nel neonato solo intorno ai 20 mesi assisteremo all’inizio del suo sforzo di rispondere ai nostri tentativi di dare un nome specifico alle sue emozioni. Per i genitori è di solito un momento topico, momento nel quale sembra prendere corpo quel linguaggio costruito pazientemente nell’intimità di una comunicazione personale che finalmente trova le parole giuste per manifestare i moti dell’animo. Questi, in precedenza venivano immediatamente espressi con comportamenti indifferenziati, senza una chiara e immediata comprensibilità; ora il bambino è capace di distinguere e portare all’esterno le sue emozioni con comportamenti molto specifici e significativi.
Il compito del genitore in questa fase si configura come il compito di fornire una presenza empatica, una base, una sorta di ancoraggio affinché il bambino si possa riflettere, sperimentarsi e imparare a contenere l’intensità delle sue emozioni, a dosarle e a esprimerle adeguatamente. E’ un compito che quasi tutte le mamme svolgono con molta naturalezza e piacere, anche se a volte con molta fatica.
Per questo scopo in generale è’ opportuno che l’adulto si lasci affascinare da un paio domande: cosa suscita in me? Che reazione ho io? Forse non abbiamo sempre la risposta pronta e nell’attesa che questa affiori dentro di noi, è anche opportuno osservare con empatia come e se il bambino reagisce all’attesa, come e se sia in grado di autoconsolarsi, di calmarsi da solo; inoltre, nel caso non fosse in grado di farlo, conviene chiedersi quale sia la modalità migliore per quel bambino di accettare un intervento esterno (capacità identificatoria primaria).
Si potrebbe dire che il pianto è una comunicazione di attaccamento del bambino alla figura che si occupa di lui. Di converso si potrebbe anche dire che favorisce l’attaccamento dei genitori al loro piccolo sviluppando la preoccupazione primaria (Brazelton, 1973). Insomma: è importante che chi si occupa del bebè sia sufficientemente sereno per non lasciarsi invadere dalle proprie ansie che potrebbero ridurre la sua capacità di pensare al posto del bambino (3). E’ dunque opportuno lasciare spazio nella propria mente, quando il bebè piange, per interrogarsi su quello che sta cercando di comunicarci.
Se i genitori sono particolarmente ansiosi e agitati di fronte al pianto del bambino tenderanno inevitabilmente a rispondere subito, e in definitiva a rinforzarlo (4), rendendo la comprensione della comunicazione più difficile.
Non è che bisogna lasciar piangere il bambino; però non bisogna neppure intervenire troppo in fretta per interrompere il pianto sotto l’impulso dettato dalla propria ansia: poiché si tratta di un richiamo primario che sollecita una risposta immediata, esso attiva spesso le nostre proiezioni e blocca il fluire libero del nostro pensiero. Non potrebbe così dispiegarsi un’area mentale nella quale dar corpo e parola al significato della sua richiesta di attenzione.
Quanto queste proiezioni possano costituire un’interferenza nella rèverie materna, cioè nella naturale propensione della madre ad assumersi empaticamente le angosce del neonato per stemperarle con la sua capacità consolatoria, lo può dimostrare un’esperienza concreta.
A un gruppo di formazione ospedaliero, è stato proposto il filmato del pianto di un neonato (livello 5 su una scala da 1 a 5). Per l’impossibilità oggettiva di intervenire e far cessare il pianto, questo filmato ha fatto affiorare nei partecipanti un senso di impotenza e frustrazione che non potendo trovare una giusta collocazione nel pensiero, è stato proiettato sulle osservatrici riprese nel filmato. Tali emozioni si sono cioè trasformate in reazioni accusatorie verso le anonime figure adulte che non erano intervenute immediatamente per far cessare il pianto: l’adulto è stato percepito come poco accogliente, poco disponibile.
I sentimenti e i vissuti del gruppo di formazione così pronti ad emergere, risultavano confusi, inarticolati e indistinti, nascosti alla stessa coscienza di coloro che li stavano provando. Emblematica di tali vissuti è stata la percezione soggettiva e distorta della durata del pianto. I partecipanti la collocavano fra i tre e i dieci minuti, durata questa molto maggiore di quella reale. Il neonato del filmato aveva pianto per un minuto e quaranta secondi. L’ipotesi di spiegazione più accreditata per quanto accaduto fu che il bisogno di fermare il pianto fosse dovuto più alla difficoltà di tollerarlo che al bisogno di aiutare il neonato. Inoltre, nella discussione successiva è emerso come il pianto sia stato vissuto esclusivamente come qualcosa di negativo, come manifestazione di un disagio e non come mezzo di comunicazione.
La rivelazione della durata reale del pianto ha prodotto nel gruppo un abbassamento dell’ansia e un netto cambiamento: si è aperta un’area di pensiero e la discussione è diventata via via più circolare e riflessiva.
Cosa possiamo trarre da questa esperienza?
Essa fa pensare all’opportunità di saper dare fiducia al bambino. Egli possiede delle grandi competenze espressive. Potrebbe essere buona cosa mantenere la fiducia di saper cogliere attraverso di esse il bisogno che viene manifestato in quel momento (la madre “sufficientemente buona” di Winnicott). Fiducia che conviene mantenere anche quando il bambino pone egli stesso delle barriere alla nostra comprensione (sprofondamento nel sonno, movimenti reattivi di irritazione, calo dell’eccitazione e dell’attenzione, irrigidimento, sbadigli, starnuti, rivolgere lo sguardo altrove, chiusura degli occhi). E il pianto è una di esse.
Il bisogno dell’adulto di placare subito il pianto del neonato prima ancora di averne capito il motivo non permette di pensare e non permette di chiedersi quali risorse può mettere in campo il neonato per calmarsi da solo.
La capacità del neonato di calmarsi da solo o di accettare interventi di consolabilità esterna, è in rapporto con l’agitazione motoria raggiunta. Al suo apice il bebè farà dei tentativi, degli esperimenti per calmarsi da solo e può essere importante osservarlo nei suoi timidi tentativi di breve durata o in quelli più decisi ma senza successo. Può essere che riesca a calmarsi volgendo gli occhi verso la luce, oppure facendo dei movimenti di suzione, oppure ancora muovendo e unendo le mani o portandosele alla bocca. Se queste manovre non giungono a buon fine è necessario un intervento esterno, ma anche in questo caso il bambino può mostrare delle competenze specifiche: p.e. si può calmare se gli si offre un dito o un oggetto da succhiare.
Oppure si calma se gli si pone una mano sull’addome e gli si tengono ferme una o entrambe le gambe: si quieta alla vista del volto e alla voce dell’osservatore.
Si può inoltre calmare vestendolo, oppure tenendolo in braccio e cullandolo… Il dondolio che quasi sempre si accompagna al contatto col bambino, ha un forte potere inibitorio nei confronti del pianto. Ma anche la competenza del bambino di rannicchiarsi quando viene preso in braccio può mettere in luce la sua oppositività, la sua accettazione passiva, …o la sua beatitudine. Ogni mamma lo sa.
NOTE
(1) Ritmo e durata del pianto daranno un prima indicazione delle caratteristiche individuali del bambino. Prechtl e altri (1969) hanno studiato le modalità del pianto nei neonati normali e hanno trovato che durata e intervalli sono molto brevi, al contrario di quelli con neuropatie che hanno un’ampia variazione di parametri quasi che questi ultimi non abbiano in dotazione meccanismi di regolazione ritmica. Ciò può avere una certa importanza in ambito diagnostico.
Nei neurolesi tutto il comportamento assume un carattere di imprevedibilità, rendendo problematiche le cure materne: si forma un involontario circolo vizioso tra l’inconsolabilità del bambino e l’inadeguatezza della madre, con vicendevole rinforzo.
(2).La comparsa delle lacrime è un fenomeno evolutivo piuttosto tardivo (e tipico della specie umana). Esse porteranno ulteriori articolazioni nella comunicazione: testimoni del dolore psichico più che fisico, sono simbolo più della fatica di vivere che di altro, e segneranno secondo Grinker (1953) l’inizio della differenziazione fra sé e non-sè.
(3) Se davanti al pianto di un bebè ci lasciamo sopraffare dall’ansia corriamo il rischio di una confusione identificatoria tra il bambino reale che abbiamo davanti e le nostre reminiscenze del bambino che noi siamo stati. La capacità regressiva e di rèverie nostra, può servire per comprendere e aiutare il bambino, ma se l’ansia prende il sopravvento può portare a una confusione fra ciò che è nostro e ciò che è del bambino.
(4) Ainsworth e Bell (1972) hanno trovato notevoli differenze individuali, sia nel pianto del neonato che nelle risposte delle madri: per questi AA. la “rapidità” della risposta materna (risposta indifferenziata) è il fattore associato con la diminuzione della durata del pianto.
Con una successiva analisi statistica più sofisticata essi hanno dimostrato come la “sensibilità materna” al pianto (risposta specifica) sia altrettanto importante per la diminuzione dello stesso in termini di frequenza: ne possiamo dedurre che se la madre non risponde in modo adeguato al bambino, egli tenderà a incrementare il pianto stesso, a scapito delle altre forme di comunicazione! Possiamo anche dedurre che i fallimenti più o meno sistematici della madre nel controllo, ma soprattutto nella comprensione del significato pianto, libererà nel neonato vissuti di frustrazione, inadeguatezza e aggressività incoerenti, con riflessi sul loro rapporto.
BIBLIOGRAFIA
AINSWORTH M.D., BELL S.M. (1974) “Mother-infant interaction and development of competence”, Academic Press, N.Y.
BRAZELTON T.B. (1981) “Nascita di una famiglia”, Milano, Unicopli, 1987
BRAZELTON T.B., NUGENT J.K. (1995) “La scala di valutazione del comportamento del neonato”, Masson, Milano,1997
FORNAR F. “la vita affettiva originaria del bambino” Milano, Feltrinelli, 1963
GRINKER M. (1953) “Psychosomatc research”, Norton N.Y.
MAHLER M., PINE F., BERGMAN A. (1975) „La nascita psicologica del bambino“ Torino, Boringhieri, 1978
PRECHTL H.F.R. e altri (1969) “A statistical analysis of cry patterns in normanand abnormal newborn infant”, in Development Medicine and child neurology, XI, 142-152
D.W_ WINNICOTT (1964) “Perché i bambini piangono?”, in Il bambino, la famiglia e il mondo esterno, RCS, Milano, 2012
WINNICOTT D.W. (1965( “Sviluppo affettivo e ambiente” Roma, Armando, 1965
WINNICOTT D.W. (1971) “Gioco e realtà” Roma, Armando, 1974





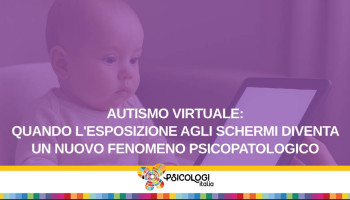
commenta questa pubblicazione
Sii il primo a commentare questo articolo...
Clicca qui per inserire un commento